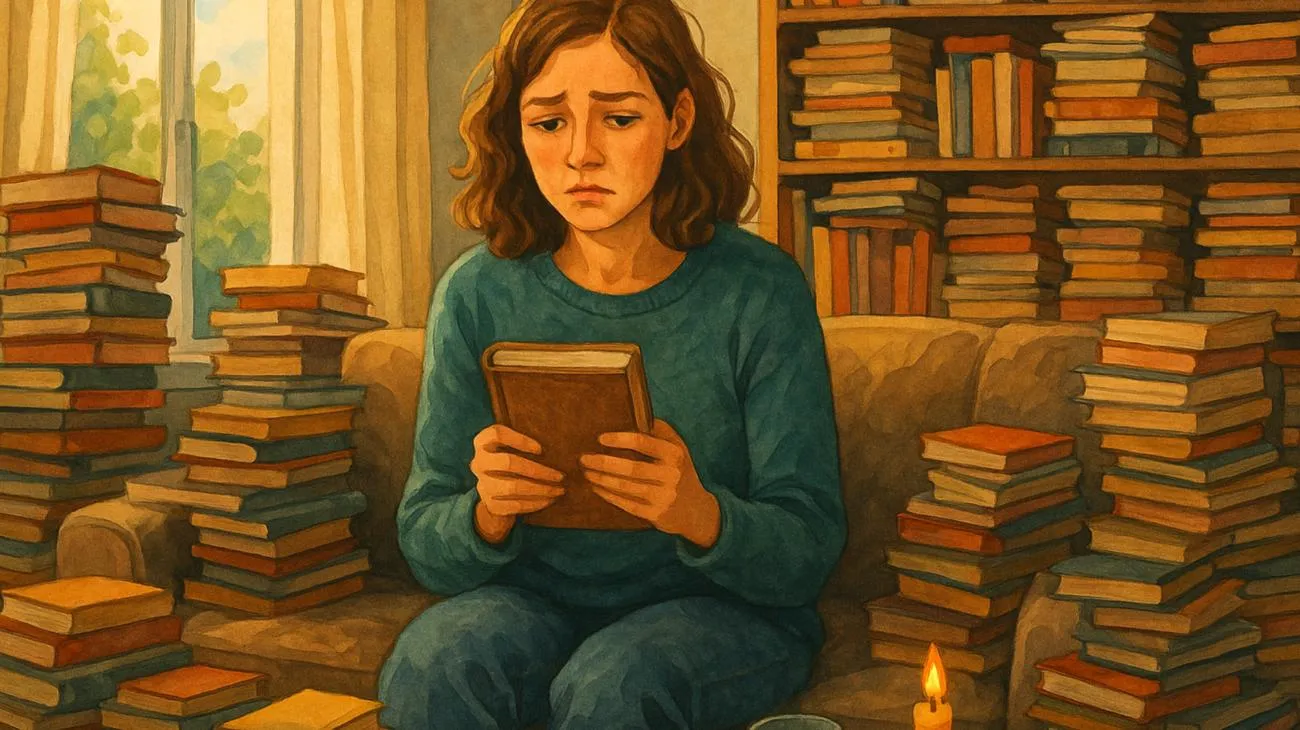Cosa significa se non riesci a buttare i libri, anche se non li leggerai mai?
Sei circondato da pile di libri che non hai mai aperto. Scaffali che traboccano di titoli che continui a rimandare. Eppure, quando pensi di liberartene, qualcosa dentro di te si blocca. “Ma questo potrebbe servirmi”, “Prima o poi lo leggerò”, “È un classico, non posso buttarlo”. Ti suona familiare? Benvenuto nel club di chi accumula libri mai letti, un fenomeno molto più comune e psicologicamente interessante di quanto si possa pensare.
Ma cosa c’è davvero dietro questa incapacità di separarci dai libri che probabilmente non apriremo mai? Studi di psicologia spiegano che le cause sono legate a meccanismi complessi di identità, memoria, investimento emotivo e anche a dinamiche sociali profonde che meritano di essere esplorate.
Il fenomeno del Tsundoku: quando comprare libri diventa un’arte
I giapponesi hanno una parola specifica per questo comportamento: tsundoku. Il fenomeno del Tsundoku letteralmente significa accumulare libri lasciandoli non letti, spesso ammucchiati in pile sempre più alte. Non è un termine moderno: risale al periodo Meiji, alla fine del XIX secolo, a dimostrazione che questa particolare forma di accumulo è una pratica culturale diffusa già da oltre un secolo.
Secondo dati del Pew Research Center del 2019, circa il 27% degli adulti statunitensi ha dichiarato di non aver letto nemmeno un libro nell’ultimo anno, eppure l’industria editoriale resta fiorente. In Italia, i dati ISTAT del 2021 confermano che solo il 40,8% della popolazione sopra i 6 anni ha letto almeno un libro nell’anno, a fronte di vendite comunque sostenute. Un paradosso interessante, che rivela quanto i libri rappresentino molto di più della semplice lettura.
I libri come specchio dell’identità ideale
Qui entriamo nel cuore della questione psicologica. I libri che accumuli non rappresentano chi sei, ma chi vorresti essere. Quella copia di “Guerra e Pace” che campeggia sullo scaffale? Parla della tua aspirazione a essere una persona colta, paziente, capace di affrontare opere impegnative. Il manuale di giardinaggio biologico? Racconta del tuo io ideale che vive in armonia con la natura, anche se abiti al quarto piano senza balcone.
La psicologa sociale Sabrina Helm dell’Università dell’Arizona ha dimostrato che gli oggetti che scegliamo diventano parte della nostra identità attraverso il concetto di “auto-estensione”: le persone usano i beni materiali per esprimere chi vorrebbero essere. In pratica, i tuoi libri diventano parte della narrazione che costruisci su te stesso, una mappa delle tue aspirazioni più profonde.
L’attaccamento emotivo agli oggetti-simbolo
Non tutti gli accumuli sono uguali. Quando parliamo di libri, entriamo in un territorio particolare dell’attaccamento agli oggetti. A differenza di vecchi vestiti o elettrodomestici rotti, i libri portano con sé un peso simbolico enorme. Secondo gli studi di Russell Belk, i beni materiali possono essere trattati come prolungamenti del Sé, particolarmente se legati al sapere, al passato personale o alle aspirazioni future.
Ogni libro non letto rappresenta conoscenza potenziale. È come avere un biglietto della lotteria non ancora grattato: finché non lo butti, la possibilità di vincere, o in questo caso di imparare qualcosa di straordinario, rimane intatta. Il neuroscienziato Antonio Damasio ha dimostrato attraverso i suoi studi su emozione e ragione che le nostre decisioni sono profondamente influenzate da marcatori emotivi: l’attaccamento ai libri non letti può rappresentare la speranza di una futura crescita o cambiamento.
La sindrome del costo irrecuperabile
Gli economisti comportamentali chiamano questo fenomeno sunk cost fallacy, l’errore dei costi sommersi. Hai speso soldi per quel libro, quindi buttarlo significa sprecare quell’investimento. La ricerca condotta da Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia nel 2002, ha dimostrato come gli esseri umani siano irrazionalmente avversi alle perdite.
Conservare il libro, anche non leggendolo mai, dà l’illusione che l’investimento non sia stato completamente vano. “È lì se ne avrò bisogno”, ci diciamo, creando una narrazione che allevia il disagio cognitivo. Buttare un libro equivale psicologicamente ad ammettere una sconfitta: riconoscere che non diventerai quella persona che pensavi di poter essere.
Quando l’accumulo diventa problematico?
C’è una differenza sostanziale tra essere un collezionista entusiasta e avere un comportamento problematico. Il disturbo da accumulo è stato riconosciuto come condizione clinica nel DSM-5 nel 2013. Si caratterizza per l’incapacità di separarsi da beni anche quando inutili, con impatto significativo sulla qualità della vita.
Studi della International OCD Foundation stimano che circa il 2-6% della popolazione generale possa soffrire di questa problematica. Ma quando si tratta specificatamente di libri, i confini diventano sfumati. La psicologa Randy Frost, una delle massime esperte mondiali di disturbo da accumulo, sottolinea che la differenza cruciale sta nel grado di funzionalità della persona e nell’impatto sulla qualità della vita.
I segnali da non ignorare includono l’occupazione di spazi vitali della casa che impedisce di usarli normalmente, ansia intensa all’idea di separarsi dai libri, acquisti compulsivi nonostante difficoltà economiche, e la sensazione di essere sopraffatti dalla quantità senza riuscire a fermarsi. È il livello di compromissione, e non l’oggetto in sé, a distinguere il collezionismo dalla patologia.
Il significato nascosto delle diverse tipologie di libri
La tua biblioteca personale di volumi immacolati è come una mappa psicologica delle tue aspirazioni, paure e valori. I romanzi classici mai aperti rivelano il desiderio di essere percepiti come intellettualmente sofisticati, ma anche la paura di non essere all’altezza. Secondo gli studi sulla procrastinazione condotti dalla psicologa Fuschia Sirois, spesso rimandiamo compiti che potrebbero rivelare nostre presunte inadeguatezze.
I manuali di auto-miglioramento rappresentano un desiderio profondo di cambiamento e, contemporaneamente, la difficoltà di metterlo in pratica. L’accumulo di questi titoli può diventare una forma di procrastinazione attiva: compri il libro sentendoti già un po’ migliorato, senza dover fare il vero lavoro che richiederebbe. Il solo acquisto dà la sensazione di impegnarsi verso il cambiamento.
La dimensione sociale dell’accumulo libresco
I libri sono anche oggetti di status sociale. Uno studio pubblicato da Samuel Gosling su Social Influence nel 2013 ha evidenziato come la presenza di libri influenzi significativamente le impressioni di intelligenza e cultura attribuite dagli altri in uno spazio domestico. Avere scaffali pieni di libri comunica, o almeno noi pensiamo comunichi, intelligenza, cultura, profondità.
Durante la pandemia, molti si sono improvvisamente preoccupati dello sfondo delle loro librerie nelle videochiamate. I libri dietro di noi funzionano come una scenografia dell’identità che vogliamo proiettare. Non è vanità, è psicologia umana: costruiamo continuamente narrazioni su noi stessi attraverso gli oggetti che ci circondano.
Strategie per liberarsi, se vuoi
Se hai deciso che è tempo di fare spazio, esistono approcci psicologicamente fondati che possono aiutarti. Il metodo della gratitudine, reso famoso da Marie Kondo, si basa sul ringraziare l’oggetto prima di separarsene. Ricerche nell’ambito della psicologia positiva suggeriscono che un approccio di gratitudine può facilitare il distacco e ridurre la sofferenza associata alla separazione dagli oggetti.
La regola della realtà suggerisce di essere onesti: se non hai letto quel libro nei primi sei mesi dal suo acquisto, le probabilità che lo leggerai diminuiscono drasticamente. Studi sulla procrastinazione mostrano che le intenzioni non realizzate entro breve tempo hanno probabilità molto bassa di concretizzarsi in seguito. La donazione, invece del “buttare”, riformula l’azione in termini positivi, riducendo il disagio emotivo e aumentando il benessere percepito.
Il lato positivo dell’accumulo letterario
Non tutto l’accumulo è negativo. Il filosofe Nassim Nicholas Taleb ha coniato il termine antibiblioteca per descrivere una collezione di libri non letti come risorsa preziosa: rappresentano tutto ciò che ancora non sai, un promemoria costante dell’umiltà intellettuale. Secondo questa prospettiva, i libri non letti non sono un fallimento ma una celebrazione della curiosità.
Mostrano che hai più interessi di quanto il tempo permetta di esplorare, che la tua mente è aperta a più possibilità di quante ne possa concretizzare. L’importante è trovare un equilibrio: va benissimo avere più libri di quanti ne leggerai, purché questo non diventi fonte di stress o problema pratico per il tuo spazio vitale.
Un autoritratto fatto di carta e possibilità
La prossima volta che guardi quella pila di libri mai aperti, prova a vederla per quello che è: un autoritratto psicologico. Ogni titolo racconta una storia su di te, sui tuoi sogni, sulle tue paure, su chi speri di diventare. Non riesci a buttare quei libri perché rappresentano potenzialità, versioni alternative di te, conoscenze che potresti acquisire.
Che tu decida di fare una grande pulizia o di abbracciare la tua antibiblioteca personale, l’importante è farlo con consapevolezza. I libri sono strumenti meravigliosi, ma non dovrebbero mai diventare catene che ci tengono legati a versioni idealizzate di noi stessi. La vita è troppo breve per non circondarsi di possibilità, anche solo teoriche, ma è altrettanto importante accettare chi siamo davvero nel presente.